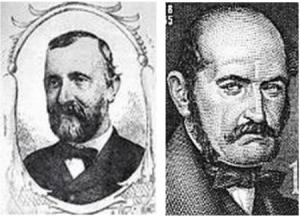Chi non ha avuto questa passioncella? Certo insieme al Lupo della steppa di Hesse ed ai trip di Castaneda e Don Juan, mentre – stranamente – sfido tutti a ricordare un amore giovanile per il Pinocchio di Collodi, che pure era allucinato gran bene. Ma con le Storie zen ci siamo fatti delle belle storie, dite la verità. E anch’io, come voi, avevo un amico zen, troppissimo zen, talmente zen che dopo un po’ mi era venuta una maligna voglia di sluminarlo. Scrissi così per lui le 10,1 Storie zen e quando egli mi chiese (ingenuamente, perché in fondo i maestri zen sono dei tatoni) “perché 10,1?” – gli risposi, secondo me in modo molto zen: “perché 11 avrebbero già rotto i coglioni”. Ora sottopongo queste storie alla vostra smeditazione. Metteteci pure trent’anni, pare che il tempo conti poco per lo zen; l’importante è che – come il mio amico – alla fine vi sluminiate, insomma vi addormentiate sereni.
**************************
PREFAZIONE
“Nel suo ultimo giorno di vita Tanzan scrisse sessanta cartoline postali e incaricò un suo assistente di impostarle. Poi morì. Sulle cartoline c’era scritto: Sto per andarmene da questo mondo. Questo è il mio ultimo annuncio. Tanzan 27 luglio 1892.”
Questo è un racconto zen, un vero racconto zen, come ci viene tramandato da una sublime letteratura volta ad insegnare, come appare, l’ineffabile arte di prendersi per il culo. Ma se invece fosse una straordinaria prova di umorismo? Cioè, se questi racconti zen, piuttosto che rappresentare la più alta vetta nella mancanza di rispetto per la ragione umana e per l’uomo in tutte le sue essenze, anche le meno puzzolenti, invece che essere una forma infantilmente presuntuosa di incapacità di approfondire il pensiero, fossero un enorme scherzo, una gigantesca burla tramandata per secoli?
Ce li immaginiamo, i maestri zen, lì a prendere il caffè: – E quello mi chiede tutto fremente: “ma sulle cartoline cosa c’era scritto?” Si aspettava chissà che, capite, allora gli faccio: “Sulle cartoline c’era scritto: Saluti e baci, Tanzan, data e timbro postale” – e giù tutti i maestri a ridere come scemi. – E io, e io, quello mi dice: “Maestro, quanto ci metto a imparare lo zen?” E io: “vent’anni”. “E se mi impegno?” E io: “trent’anni”.Vedessi che faccia! Eh, ma sei proprio uno stronzo! – e giù risate.
E’ interessante notare che alcuni lettori giapponesi considerano i tradizionali racconti zen parte di una eccezionale letteratura comica, forse un tempo recitata da attori itineranti nelle corti degli antichi regni, per svagare i sovrani incazzosi, al pari della tradizione europea della Commedia dell’arte.
Bello, no? Questo metterebbe tutto a posto, sarebbe una bella scoperta, ci riconcilierebbe con l’animo orientale di cui non capiamo un cazzo sì, ma perché era uno scherzo, in realtà i nostri fratelli asiatici non sono pazzi o imbecilli, ma uomini di buon senso che non crederebbero mai bastino due chiacchierelle oltretutto veramente sceme per “illuminarsi” nientemeno che su un fantomatico senso dell’universo, eh via!
Dunque, ebbene è proprio così, vedete; una lunga ricerca filologica e scettica ha scoperto in polverosi archivi della dimenticata tradizione filosofica orientale antica, scritti che risolvono il mistero da sempre presente come un’ombra folle su tutta la storia del continente asiatico: la letteratura zen è uno scherzo da Amici Miei, antichi buontemponi che ne hanno dette di tutti i colori, per divertirsi alle spalle dei contemporanei. Chissà come riderebbero vedendo cos’hanno combinato ai posteri.
Questi simpatici (e pericolosi) personaggi, però, non hanno inventato niente: si sono limitati a parodiare racconti popolari realmente esistenti a quei tempi dando loro un senso quanto più possibile astruso e si sono divertiti tanto che dalle 10,1 storie tradizionali, ne hanno ricavate addirittura 101; anche da questo eccesso si evidenzia, se mai ancora ce ne fosse bisogno, la prova dello spirito goliardico che animava i “maestri” Tanzan, Sen No Rikyu, Gasan, Subhuti, Hakuin ed Alessandro Bottolenghi.
I racconti veri, originali, parodiati dal gruppo, sono ora presentati in questa raccolta: si tratta di storie serie, naturalmente, a volte drammatiche, molto reali ed umane comunque, alcune forse noiose, come a volte è la vita, in ogni caso sicuramente assai meno divertenti delle “101 Storie Zen” della tradizione, ma vanno conosciuti per curiosità, per cultura e perché non si pensi che in Oriente non si pensi. Un utile glossario aiuterà il lettore a familiarizzarsi con il mondo dei valori narrato nelle storie che seguono. Buona lettura.:
GLOSSARIO
BUDDISMO: Forte il buddismo: si differenzia dalle altre supposte perché non ti promette di arrivare ad ammirare il sacro volto di dio, come da noi, che non sembra un programma interessante, soprattutto nell’eternità, oppure, come fanno gli arabi, stare per sempre a darci come un coniglio con le Urì (e va già meglio, vero, però alla lunga…) o svanire e fottersene come gli indù. No, qua si tratta di DIVENTARE dio, ragazzi, mettetevi d’impegno orca, studiate.
FIORE DI LOTO: Non si sa che cazzo c’entri sempre il Fiore di Loto: è come se noi che abbiamo l’agrifoglio, detto pungiculo, mettessimo il pungiculo in ogni nostro romanzo come personaggio di spalla; al minimo gli altri personaggi si iscriverebbero subito nelle liste di collocamento. Come insegnano Pirandèllo e Queneau, infatti, queste sciocchezze non si possono fare impunemente.
GIAPPONE: Il Giappone che li ha creati, se ne fotte dei raccontini Zen avendo soddisfatto il lato spirituale dell’esistenza con qualche bagno sociale in sottoscala irti di bonsai trompe l’oeil per far credere di stare in un vero giardino, una volta nella vita. In compenso il contante Yen fa, al mondo che si diverte, un sedere tanto.
KYOTO: Città. Fa il trio con Washington e Genova delle canzoni di Dalla e Bruno Lauzi. Non serve a niente andarci, quindi. C’è poi sempre il rischio dell’illuminazione, a Kyoto.
ILLUMINAZIONE / ATO: Cfr. Abelinazione / ato.
MAESTRO ZEN: Il contrario del Maestro Manzi. Per il Maestro Zen non è mai troppo presto per rincoglionirsi. Nella Tradizione Scettica Universale l’apparizione di un Maestro Zen è ritenuta segno di sciagura.
MEDITAZIONE: Dipende: è come un cono gelato, può essere piacevole o malefico secondo come lo usi. Nell’accezione zen comunque, il significato è racchiuso nella massima di Goya: – “Il sonno della ragione, vuoi vedere che ti genera la meditazione?”.
RACCONTO ZEN: Detto anche “Koan” o “Cerchio Eterno Alla Testa”, è una filastrocca ipnotica alla maniera delle occidentali parabole, prediche, salmi, orazioni, consigli per gli acquisti e quant’altre supposte conoscete. Raccomanda, con sorprendente originalità, l’affrancamento dal contingente a cominciare dalle femmine (o maschi) sempre tanto superflue, per concludere con il distacco da meschinità quali il cibo e l’aria, senza dire dei soldi, così poco necessari.Grazie al Racconto Zen, l’Oriente e l’emisfero australe sono arretrati di cinquecento anni rispetto a qui e la gente, conscia della propria superiorità morale, crepa filosoficamente de fame; eh beh.
RITUALE DEL TE’: E’ una roba difficilissima da capire se non avete mai sofferto di compulsioni schizoidi e varie ossessioni fobiche che però i Maestri del tè (!) sublimano in un’arte densa di grazia e soavità deliziose, costruendo con gesti millenari e pregni di significati, una atmosfera di studiato abbandono e di comunione intima con tutto il creato; peccato che il tè caldissimo il più delle volte faccia scorreggiare tanto.
SLUMINAZIONE: Evento fortuito o provocato recante in sé la potenza del “Desciùles”, la Sveglia Primigenia, il Grande Affrancamento dai gesucristi di ogni latitudine e la piena riduzione dell’onanismo mistico alla salubre consuetudine del realistico pensiero sociale; la realizzazione infine, e scusate se è poco, del sé sull’erba dei nostri pascoli, evitando di confidare nei Verdi Pascoli, un tantino troppo Verdi.
Dice infatti il Maestro Woody Allen: – “Signore, tu mi fai sdraiare sui Verdi Pascoli, il problema è che non riesco ad alzarmi”.
ZEN: Sorta di infatuazione, o infezione, psicologica affine al delirio di onnipotenza, all’allucinosi eidetica ed altre bazzecole così; nella Tradizione Scettica Universale si configura come un “omen”, un triste presagio, come ad esempio la frase “Ti voglio bene come ad un fratello” detta non dalla sorella; il manifestarsi dello zen può essere seguito da un accadimento funesto, quale ad esempio una fissazione egotistica per i muri, che può portare ad osservare una parete per dieci anni nella speranza di conoscerla meglio. In tali casi è quanto mai efficace la forte sluminazione prodotta dalla badilata di un muratore volenteroso.
****************************
0,1 – CHE COSA CERCHI ? –
Daju fece visita al maestro Baso in Cina. Baso domandò: – “Che cosa cerchi?” “L’illuminazione” – rispose Daju. “Beato te, io la sluminazione” – fece il maestro.
1 – PIOGGIA DI FIORI –
Subhuti era discepolo di Buddha, era capace di capire la potenza del vuoto, il punto di vista che nulla esiste se non nei suoi rapporti di soggettività e di oggettività.
Un giorno Subhuti, in uno stato d’animo di vuoto sublime (1) era seduto sotto un albero; dei fiori cominciarono a cadergli tutt’intorno.
Ti stiamo lodando per il tuo discorso sul vuoto” gli mormorarono gli dèi.
Ma io non ho parlato del vuoto” disse Subhuti.
Tu non hai parlato del vuoto, noi non abbiamo udito il vuoto: questo è il vero vuoto” risposero gli dèi, e le gemme cadevano su di lui come una pioggia.
E vabbè. Un’altra volta Subhuti, mentre stava placidamente sotto un pero, in preda ad una sensazione di russante non-essenza, fu svegliato da certe voci seccate che ripetevano:
“Oh, beh, ora non ci è mica piaciuto il tuo discorso sul vuoto, neh, hai detto un sacco di cazzate!” – E giù una pioggia di calci sui denti.
“Aaahh!! Non ho detto niente! No no aiuto anzi cioè, stavo proprio parlando del vuoto, quindi non c’era il vuoto, no? Ahia ahia ahia!!!… E andate tutti affanculo insomma!….” gridava Subhuti, correndo a zig-zag e sluminandosi progressivamente.
(1) Metafora giapponese per: “dormiva come un orso”
2 – UNA PARABOLA
In un Sutra, Buddha, pasticciando come suo solito, racconta una parabola che noi riportiamo nella versione corretta
Un uomo che camminava in un campo si imbatté in una tigre. Si mise a correre, tallonato dalla belva; giunto ad un precipizio, non potendo proseguire si afferrò ad una radice di vite selvatica lasciandosi penzolare nel vuoto.
Dal fondo dell’abisso lo raggiunse il suono di una gutturale risata: era il marito di quella tigre di prima, un’altra tigre naturalmente, che lo guardava aspettando; nel frattempo due topi, uno bianco e l’altro nero, avevano cominciato a rosicchiare la vite.
Rotta la vite, l’uomo cercò disperatamente di agguantare un ramo di ciliegio (tutto fiorito) ma gli rimase inspiegabilmente in mano una fragola selvatica. Mentre cadeva nel vuoto con la sua fragola selvatica, esperendo la soggettività nell’oggettività, il vuoto sublime e tutto il resto, l’uomo ebbe il tempo di profferire:
“Eh, ma che sfiga stamattiiiii…….!”
3 – IL SUONO DI UNA SOLA MANO
Un giorno Koichi andò dal maestro Mokura perché questa storia della sola mano gli aveva proprio rotto l’anima.
La sua ragazza continuava a dirgli: “sì vabbè, ma con una sola mano? Mokura ci riesce e tu? Che delusione.”
Suo padre mormorava, guardandolo severamente: “Ah, che roba. Sarai anche un economista di successo, ci avrai comprato la villa col motoscafo, ma io e tua madre, avere un figlio con due mani!…” e andava via scrollando la testa.
Gli amici ed i colleghi di partito lo sfottevano mettendo una mano dietro la schiena ed agitando l’altra tra grasse risate, mentre il fido bancario che aveva chiesto andava parecchio per le lunghe perché, gli spiegavano, “qui da noi si lavora con una mano per volta, non siamo dei maneggioni”.
Dunque il giovane Koichi si presentò al tempio chiedendo del maestro, ma a chiunque lui si rivolgesse, nessuno sapeva dove quegli fosse, né ove trovar qualcun che lo sapesse.
Koichi cercò e vagò, perdendosi nel grande tempio come i mortali nell’esistenza finché, definitivamente rottosi, aprì una porta a caso e lì ecco Mokura, con la sua segretaria. Come tutti potevano vedere, stava irrefutabilmente usando tutte e due le mani.
Da quel giorno Mokura non ruppe più i coglioni ad alcuno.
4 – MI CONVIENE FARE IL PIRLA?
Al maestro zen Zun Zan capitò un giorno di incontrare un samurai ubriaco che gli chiese minacciosamente: “Ehi, è questa la strada per Kyoto?”
“…Non è forse la strada dei fiori di loto?…” rispose il maestro, con la tipica flemma zen.
Il soldato lo squadrò e disse:
“Ma che cazzo fai, mi prendi in giro, deficiente??!” e gli menò un terribile fendente, dimenticandosi però di impugnare la spada.
Mentre fuggiva a seicento all’ora, Zun Zan fu sluminato.
5 – AH SI’?
Uno dei ‘koan’ più famosi è senza dubbio quello intitolato “Ah sì?” dove, secondo certa tradizione letteraria, il maestro zen Hakuin fa la figura del babbeo.
Dopo lunga ricerca, tra gli scaffali polverosi del buonsenso giapponese abbiamo trovato la versione autentica del racconto, nella quale si rende giustizia al signor Hakuin da secoli rappresentato come un mezzo deficiente.
Il maestro Hakuin era decantato dai vicini per la purezza della sua vita.
Accanto a lui abitava una incredibile fotomodella pazzesca, che si pettinava e stendeva biancheria intima sulla veranda della casa, oppure pigliava il sole sul tetto ed anche se non era possibile vederla lo si sapeva perché si trovavano per terra gli uccellini tramortiti; insomma, com’è come non è, ‘sta ragazza, zac: incinta.
La cosa mandò i genitori su tutte le furie, tanto più che la malaccorta non voleva confessare chi fosse il complice nella faccenda, ma infine, davanti alla minaccia di uno, o anche due apologhi zen, disse subito trattarsi del maestro Hakuin.
I genitori ed i parenti, furibondi, andarono dal maestro: “Ah, buongior…” fece in tempo a dire Hakuin, che stava meditando, poverino; i parenti gli diedero una valanga di legnate e se ne andarono, lasciandogli il marmocchio.
Appena uscito dal grandissimo ospedale per maestri zen, Hakuin si diresse giù al fiume, dove le ragazze facevano le abluzioni di rito; beccata la fanciulla così le parlò:
“Senti un po’, brutta zoccola da mezzo koan: che ti è saltato in capa di dire che io ti avrei incinzio… incingiuto o che altro cazzo di come si dice (1); io mi sono preso un sacco di sberle per ‘sto scherzo di merda, e sono anche disonorato; io che ero sempre lì a meditare come un fesso mentre tutti intorno si divertono e poi contavo gli uccellini in deliquio ai piedi della tua casa e sa Buddha la fatica che facevo la sera ad addormentarmi. E allora? Che cacchio ti è preso, porco judo? (2)”
“Oh Hakuin” – disse la ragazza col suo più bel sorriso che mezzo sluminò il maestro – “io so che tu sei un santo e che mai mi avresti toccata, perciò ho voluto donarti l’illusione di aver avuto la fanciulla più bella della regione; tu mi insegni d’altronde che le idee e la realtà sono le due facce di una stessa menata… cioè, moneta, perciò credo che tu mi debba della riconoscenza”.
“Ah sì? ma senti; bè, mo’ te la do io l’illusione” disse veloce Hakuin, e chiuse la porta (3)”
Dieci anni di astinenza diedero ad Hakuin la spinta necessaria per compiere il gran passo; ed infatti, mentre ululava, fu sluminato.
(1) I maestri, sempre lì a meditare, poi cascano sui verbi!
(2) Antica imprecazione giapponese
(3) E’ vero che la scena si svolge in riva ad un fiume, sul limitare di un bosco, ma Hakuin, essendo maestro zen, chiude la porta dove gli pare.
6 – QUASI UN BUDDHA :
Uno studente universitario che era andato a trovare Gasan gli domandò:
“Gasan, vecchio ciula, hai mai letto la Bibbia cristiana?”
“No, cazzo” – rispose Gasan – “sono quaranta anni che sto qui sul ghiacciaio del Fujiyama e mi spediscono sempre pubblicità di palestre di judo e quel Reader’s Digest di merda! Leggimela tu”.
Lo studente lesse da San Matteo:
“…E perché ti preoccupi delle vesti? Guarda come crescono i gigli del campo: essi non lavorano eppure io ti dico che neppure Salomone era addobbato come loro; perciò non darti pensiero del domani, perché sarà il domani a pensare alle cose…”
Gasan faceva tanto d’occhi.
Lo studente continuò a leggere: “…Chiedi e ti sarà dato, cerca e troverai, bussa e ti sarà aperto perché colui che chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa gli aprono, no?”
Gasan commentò:
“Ohimé che crisi… anche in occidente hanno questo qua che dice minchiate quasi come un Buddha… veh che è una bella fregatura: e io che volevo emigrare, porca la vacca sacra del Bodhidarma di una…”
“Ma no Gasan, vecchio ciula” – riprese lo studente – “qua dice che lo hanno messo in galera, quindi gli hanno menato e per finire lo hanno appeso a monito delle genti come lui; se n’è dovuto scappare nel Regno dei Cieli, figurati un po’!”
“Cacchio!” – disse Gasan illuminandosi tutto (si fa per dire) – “ma allora sono vaccinati lì!!!”
Acchiappò la valigia ed i vecchi sci e si slanciò dal ghiacciaio, jodelando.
7 – BREVE INCIDENTE
Famoso fu, malgrado il suo breve apostolato, il maestro zen Alessandro Bottolenghi, un emigrante distratto che aveva sbagliato nave ed appena giunto a Kyoto si beccò l’illuminazione (1) divenendo all’istante e suo malgrado, maestro di zen appunto.
Mentre era a letto, tutto acchiappato dall’illuminazione che lo faceva certo di ogni cosa e del suo contrario, comprensibilmente depresso, entrarono due ragazze del luogo i cui nomi figuràti, secondo il simpatico uso orientale, suonavano come: ‘Candida Nuvola Illuminata Dal Sole Nascente, Circonfusa Di Grazia Soave, Mirabile Nel Sogno Mattutino E Pure Un Po’ Ninfomane, D’altronde’ e ‘Fiore di Loto Arrapato’; le giovani entrarono e chiesero al maestro di mostrar loro il suo zen.
Con le lacrime agli occhi il Bottolenghi stava per emettere una tipica sentenza zen, quando Candida Nuvola ecc. ecc., fissandolo negli occhi gli chiese, con voce un po’ roca:
“Sei straniero, tu, vero…?”
Fiore di Loto Arrapato si sedette sulla sponda del giaciglio e, cominciando a speluccare la coperta disse, con voce densa:
“Come sei bello, maestro, vedi, a noi, dello zen, sinceramente proprio…”
Alessandro Bottolenghi fu subito sluminato.
(1)“Contro illuminazione, niente vaccinazione: (proverbio giapponese):
8 – IL MAESTRO DEL TE’ E L’ASSASSINO
Sen No Rikyu era maestro di Cha-no-yu, il rituale del tè ed insegnava quell’estetica espressione di serenità e di appagamento a Taiko, signore dell’era Tokugawa.
Ma l’aiutante di Taiko, il guerriero Kato, vedeva nell’entusiasmo del suo superiore per il cerimoniale del tè soprattutto una certa incuria degli affari di Stato, e perciò decise di fare al maestro del tè ed al suo cacchio di rituale una visita delle sue.
Si presentò alla casa del maestro e fu da lui invitato a bersi il tè, che non gli piaceva per niente.
Il maestro Rikyu, che era molto esperto nella sua arte, invitò l’ospite ad accularsi in terra, secondo la moda giapponese; quando Kato si fu acculato, il maestro disse: “adesso preparo il tè” ma, leggendo nell’animo del guerriero le sue intenzioni, improvvisamente rovesciò ogni cosa, riempiendo la stanza di vapori e di cenere. Quando la polvere si diradò Kato si accorse che il maestro gli aveva ciulato i documenti.
“Ed ora chi sei?” chiese il maestro al guerriero, sorridendo.
Kato guardò il maestro che teneva delicatamente in mano i suoi documenti e capì d’aver capito. “E’ così che tu prepari il tè?” – gli domandò.
“C’è un altro modo?” – replicò calmo il maestro.
“Beh” – rispose Kato, sempre acculato – “sì, ci sarebbe quello di far bollire l’acqua e schiaffarci dentro le foglioline, poi coprire tutto per cinque minuti ed infine servire caldo dopo averlo filtrato. A me fa schifo”.
“Come come come?” – Disse Sen No Rikyu vivacemente – “cos’è ‘sta storia, fa’ un po’ vedere, che mi sta venendo uno strano dubbio…”
Kato, il guerriero, irto di spade e pugnali, frecce, picche e alabarde, catafratto di acciai lucenti, ornato di stemmi e guidoni, paludato di mantelli svolazzanti e pavesato di piume, penne d’aquila, di pavone, bandiere, straccetti e girelli multicolori, s’alzò con un po’ di fatica e andò sospirando in cucina.
“Ecco” – disse versandolo nella tazza del maestro – “è così che si fa il tè, vecchio rimbambito”.
Sen No Rikyu mirò il liquido fumante e brunastro, lo portò alle labbra e disse:
“Ma è vero! O ma che cacchio!…” sluminandosi immantinente.
9 – IN CHE MODO L’ERBA E GLI ALBERI OTTENGONO L’ILLUMINAZIONE :
L’erba e gli alberi non so, ma il cane di Joshu un bel giorno entrò festosamente nella stanza dove il suo padrone si stava giusto facendo un albero, nel narghilè, ed aveva riempito l’ambiente di fumi così grevi che Koan (era il nome del fedele animale) al primo respiro già si credeva un rospo di palude ed alla terza profonda inspirazione buddista era convinto (a ragione) di essere diventato maestro zen. Joshu, resosi conto di ciò che capitava al suo buon Koan, balzò in piedi tentando di spegnere l’immane canna, ma era troppo tardi; il cane aveva assunto una postura a fior di loto (peccato per la coda, che emergeva di tra le zampe fino ben oltre il punto Hara) e sentenziava mugolii omnicomprensivi.
Joshu era molto angosciato: per riportare l’animale nel suo stato comune catturò il gatto del vicino e lo mise davanti a Koan il quale, per via che stava meditando, non lo considerò minimamente; il gatto invece s’illuminò e si mise tosto in pellegrinaggio, con urla terribili.
Joshu si mise a lanciare un bastone, incitando Koan a riportarglielo, ma il cane zen gli rivolse un lungo apologo, tutto guaìto, sulla necessità etica del flusso siderale; poi gli addentò una chiappa per illuminarlo.
Joshu, sempre più costernato, portò all’animale una straordinaria bistecca di filetto che conservava cupidamente per sé, ma Koan ora stava in equilibrio sulle orecchie e non era disponibile alle vanità terrene.
Passò così del tempo, durante il quale il povero Joshu si lambiccava il cervello giapponese per trovare un rimedio alla tragedia che aveva indirettamente provocato, quando d’un tratto egli si accorse di uno strano mutamento nel contegno del maestro zen: il cane si grattava la capoccia con aria interrogativa; l’effetto del cannone stava infatti svaporando e lo scioccato animale infine si sluminò, tornando ad occuparsi solo delle proprie pulci.
Joshu, rincuorato, festeggiò l’evento con una cannarella d’erba accettabile, da fumarsi con il ritrovato Koan in letizia e senza pericoli.
10 – CONOSCI TE, FESSO:
Il maestro Tamura considerò con lo sguardo il suo discepolo e quindi così gli parlò:
“sei un pirla”.
Improvvisamente il discepolo si illuminò: “sono un pirla! Sono un pirla!” – gridava al colmo della felicità, ed il cosmo tutto vibrava d’assenso a quelle parole – “ora so cosa sono: un pirla! È così, maestro!”
“No” – rispose Tamura.
Il discepolo si fermò a mezzo di un salto mortale:
“perché, Maestro?” – domandò – “Tu hai detto che sono un pirla ed io ne ho finalmente preso coscienza: grazie alle tue parole ora conosco la mia intima essenza e so di essere un pirla; in cosa ho sbagliato?”
“Ma cosa vuoi sapere, se sei un pirla” – disse il maestro.
Il discepolo rifletté: – “Allora non sono un pirla, maestro?” – gemette, e le lacrime inondarono i suoi occhi.
Il maestro Tamura lo guardò scrollando il capo:
“sì, sei proprio un pirla” – concluse.